“If you think artists are useless, try to spend your quarantine without music, books, poems, movies and paintings”: così Stephen King, su Twitter, ormai un mese fa.
È un dato di fatto che l’arte, nelle sue più eterogenee declinazioni, sta salvando le nostre esistenze in quarantena. Ferme le attività di prestito di biblioteche e massicciamente ridimensionata l’industria discografica, sono state le nostre librerie (e simili) a donarci la materia vitale che la reclusione poteva mettere – e di fatto ha messo – in serio pericolo. Anzi, probabilmente la quarantena, costringendoci a ripensare la nostra quotidianità e il nostro rapporto col tempo, ci ha paradossalmente insegnato una virtù eccezionale, per quanto sempre più smembrata nella frenesia del moderno: la calma, ovvero la condizione necessaria alla fruizione artistica. Inoltre, molto è stato il tempo per attingere ad un passato di libri e cd accumulato in mensole paterne e polverose, altrimenti destinato – probabilmente – a trapassare nell’oblio.
Non solo. Il silenzio del momento pubblico e la solitudine che tanto abbiamo goduto (o ripugnato) durante questi mesi ha causato un fenomeno ben più grande: una metamorfosi percettiva dell’individuo nella sua fase di imbozzolamento. Reclusi nelle quattro pareti delle nostre abitazioni e disabituati agli stimoli distrattivi che ci affollano le vite di là fuori, è accaduto – in genere – un notevole potenziamento di alcuni sensi che generalmente sono scarsamente considerati: su tutti, l’olfatto. Sfido chiunque a negare quanto, una volta ritornati ai nostri ambienti, sia aumentata la finezza percettiva del nostro naso: con leggerezza ed allegria, abbiamo passeggiato con un cielo “sempre più blu” e riscoprendo, in un’aria finalmente più pulita, il profumo dei fiori di maggio. Questo ha una notevole conseguenza: semplificando l’esperienza sensoriale alla coppia privilegiata di vista e udito, il digitale – ovvero l’unica via percorribile per mantenere vivo il proprio rapporto con l’artista – ha mostrato i suoi limiti intrinseci. La nostra metamorfosi in percettori potenziati ha mostrato l’inettitudine di questa (necessaria) semplificazione.
Soffermiamoci su questo punto. Lo scivolamento dal reale al virtuale, per quanto inevitabile, ha portato vantaggi e svantaggi, sia dalla parte del creatore sia dalla parte del fruitore. Innanzitutto, è opportuno riconoscere come il tanto demonizzato social abbia permesso un rapporto col proprio artista impensabile agli inizi del millennio: il musicista ha mantenuto in vita se stesso attraverso il proprio avatar digitale, mostrandosi anche nella sua normalità di essere umano, utente al pari degli altri utenti. Attraverso format decisamente innovativi, su tutti la diretta Instagram, ha potuto riprodurre un’interazione pseudocorporea con la propria fan base, rispondendo personalmente alle loro domande ed incrociando idealmente la propria voce con quella palpitante del suo seguace dall’altra parte dello schermo.
Come si può riconfigurare il concerto?
Questo avvicinamento virtuale, tuttavia, ha prodotto un cambiamento di non indifferente portata: se sino ad ora l’artista, mostrando se stesso solamente in occasioni eccezionali (i concerti, gli instore), confermava il suo statuto extra-ordinario di “divo” – retaggio di una sacralità che il moderno ha dissipato in una pluralità di luoghi ed eventi – ora la disponibilità a tutti e in ogni momento dell’accesso alla sua persona ne ha desacralizzato e radicalmente umanizzato la statura apparentemente oltreumana. In altre parole: esponendosi a tutti “in carne ed ossa”, ha smesso la sua eccezionalità di artista, che si manifestava solo in certi momenti. In secondo luogo – è questa la conseguenza più grave – l’oscillazione verso il virtuale ha prodotto effetti disastrosi sull’industria discografica e su quella dello spettacolo. Considerato che il giro dei live fattura mondialmente circa 23 mld €, si è prevista una perdita solo in quel settore di 5 mld, cui si aggiunge il dramma che stanno vivendo i lavoratori occasionali – in Italia 60 mila – del mondo dei concerti e dello spettacolo (fonici, tecnici delle luci, operai di varia natura, etc), sino ad ora destinati di scarsa attenzione da parte dei decreti governativi (per questo lo scorso 31 marzo è stata presentata ai Ministri per l’Economia e per le Attività culturali una petizione di sensibilizzazione e aiuti concreti, concertata dalle maggiori industrie discografiche italiane). Se il rinvio di festival imponenti come il Coachella e l’Eurovision Contest sono gli aspetti più visibili di questa crisi totale, v’è un sottotesto ben più problematico legato al calo del fisico (tra marzo e aprile, secondo FIMI, del 70%), alla chiusura degli esercizi commerciali, al mancato versamento dei diritti d’autore e persino alla diminuzione della grossa fetta di streaming nel tragitto casa-lavoro: Assomusica ha stimato per l’anno 2020 una perdita complessiva in Italia di 350 mln €.
Si venga ora al punto focale: i concerti. Se per i mondi cinematografico e museale è possibile una riapertura con le dovute precauzioni (norme igieniche, distanziamento degli spettatori, etc.), ciò non vale per i concerti. Gli ingressi contingentati, scaglionati ad orari e a capienza ridotta, non impediscono che la riapertura dei live sia con ogni probabilità da rinviare al 2021, come ha affermato a FQMagazine l’assessore alla Cultura del comune di Milano, Filippo del Corno. Questo, che è quasi un dato di fatto, porta noi tutti alla domanda: che ne sarà dei concerti? Ottimisti e pessimisti si dividono sulle potenzialità che vi sono nell’unico formato ora praticabile, quello del concerto in live streaming. Il recente successone di Travis Scott su Fortnite ha dimostrato che a livello numerico la via è percorribile e potrebbe essere addirittura vantaggiosa, se si pensa alla disponibilità dello streaming in ogni angolo del mondo, senza le spese necessarie al viaggio e al soggiorno. Tuttavia, vogliamo qui affermare che tale formato non solo lederebbe l’essenza del concerto, ma la dissolverebbe del tutto, al punto che sarebbe opportuno parlare non più di ‘concerto’, ma di ‘esperienza virtuale di ascolto individuale’.
Come suggerisce l’etimo latino, infatti, il concerto si compone di una ineliminabile compresenza di corpi e di sguardi, un gioco simultaneo che incrocia artista e spettatore, o spettatore e spettatore. In un live, il suono si fa anche dei silenzi di attesa e degli impercettibili rumori che dal pubblico emanano, delle grida di estasi e del delirio dei corpi che saltano e sudano, uniti in un corteo di individui che rasenta la fusione mistica. L’artista, ben simile a un idolo, si fa largo con la propria voce in una trama di urla e preghiere che sembrano coprirne – per farla risaltare di più – l’essenza eccezionale. Il concerto è un’esperienza percettiva densa e multiforme, di cui ora – come detto sopra – noi individui sensorialmente potenziati abbiamo un immane bisogno. Nonostante i vantaggi concernenti anche la qualità dell’audio e della regia, questo nuovo concerto irreale “di camera”, che finge di guardare ad ognuno e in realtà non guarda nessuno, non può che demolire del tutto il suo presupposto essenziale: la presenza-distanza dei corpi nello stesso luogo, ovvero quell’alone impercettibile abitato dal pubblico in cui la voce e la gestualità del divo si sedimentano e si sublimano.
A più di mezzo secolo da Woodstock (ndr. alleghiamo un documentario per i più curiosi e per chi non conoscesse la portata dell’evento) , l’inno totale ai corpi e ai sensi di quell’agosto 1969, il mondo della musica si trova ad affrontare una prova secolare: il concerto, questo luogo privilegiato della sua espressione e fruizione, riuscirà a ritrovare quella traccia del sacro che i tempi sembrano mettergli in discussione?
Di Marco Palombelli e Riccardo Bellabarba, con la gentile partecipazione di tutta la redazione.
Seguiteci su Instagram!
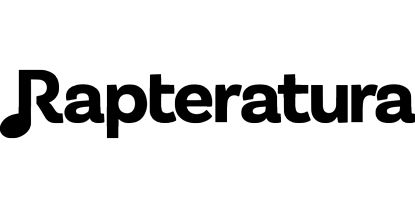







Nessun commento!