A chi si fa di Dogo come un tossico con l’oppio
CLub Dogo – Per La Gente (Che Bello Essere Noi, 2010)
E pure a chi ci odia perché lui ci ascolta il doppio
A quelli che la notte sono in giro e che si sfondano
A chi bestemmia perché le preghiere non le ascoltano
A chi si sveglia e vede questa merda tutto intorno
E studia tutto il giorno per avere tutto un giorno
Per la gente. C’è una traccia che porta questo titolo, da cui sono tratti i sei versi che hai letto all’inizio di questa recensione. Dalla gente, per la gente: per chi odia, per chi ama, per chi mangia e per chi viene mangiato, per l’ultimo reietto di strada e per chi vive sulla vetta del mondo. I Dogo sono di tutti, e lo sono sempre stati. Come una rivoluzione, che dorme ma non muore.
Anche se non li hai vissuti, la loro rivoluzione ti sta bruciando sulla pelle. E quelle cicatrici hanno ricominciato a farti male, perché era anche a te che parlavano, quando il loro ritorno ha cominciato a scalpitare. Tu eri sui motorini che sfrecciavano nei trailer che hanno annunciato gli album; eri tra quei ragazzi con la faccia nascosta che animavano le clip, che gridavano il ritorno dei giganti: sulle loro felpe, a lettere capitali, bianco su nero, bruciava la scritta “CLUB DOGO IS FOR THE PEOPLE”.
Le loro mosse di marketing hanno avuto il sapore della sommossa che si è consumata nell’immaginario di una bandiera nera sventolata dai più alti palazzi di Milano, con il cane tricipite sfolgorante: come se una nazione di sommersi fosse chiamata a riemergere dal cemento delle strade della città. E sotto gli strati dell’asfalto le parole hanno cominciato a correre, prima delle musica: sfolgoravano i versi delle canzoni affissi sui cartelloni nelle metro di Milano, strisciando in quel sottosuolo che i Dogo hanno mappato per dieci lunghi anni.
I colori del ritorno sono stati il bianco e nero, dai trailer alle foto che il trio ha postato sui social, fino ad arrivare alla copertina del disco, di cui già abbiamo parlato. Quegli stessi colori avevano cucito gli smoking e l’estetica di “Noi Siamo il Club”, degli ultimi Dogo, quelli in giacca e cravatta. La panetta di cocaina sulla copertina dell’album “Club Dogo” sembra parlare un’altra lingua, e traccia una linea che congiunge la decade in cui il trio ha imperato in Italia.

I Dogo sono stati tutto quello che volevano, correndo lungo l’intera parabola del successo: sono stati la voce della controcultura con “Mi Fist”, la punta dell’industria quando hanno smesso di essere quelli di Mi Fist. Allora chieditelo: cosa sono i Club Dogo dopo dieci anni? Nel 2024 chi sono le tre test del dogo argentino?
Lo hai sentito il sangue delle vene scorrerti quando hai riprodotto la prima traccia? Il tonfo al cuore quando “C’era una volta in Italia” è partita? Quando hai sentito Do-do-don joe esploderti nelle orecchie? Anche il tuo sogno da zanza si è avverato? Sì, il disco si apre con un pugno, il campionamento della fisarmonica crea l’atmosfera che ti spacca la faccia. Guè incastra rime, e poi arriva Jake e il tempo si è fermato. A spiegarti perché i Dogo sono tornati ci pensa la Furia, dopo poche barre:
“E sono ancora qui per colmare quel vuoto (Seh)
Club Dogo – C’era Una Volta In Italia (Club Dogo, 2024)
Perché le casse non suonavano come coi Dogo (Yeah)”
Immagina la scena rap italiana, come un alveare. Le celle sono perfette, armoniche interconnesse. Ognuna è al suo posto, incasellata nell’ordine fissato, ognuna con il suo ruolo e le sue unicità. Al centro di questo reticolato perfetto, resta un enorme cratere: manca la regina. In tutti questi anni, quella voragine non si è mai riempita; nessuno ha avuto l’ardire di sedersi sul trono. Il cane a tre teste si è rimesso la corona in testa, come ti ricorda l’ultima barra del brano: togliete i piedi dal tavolo, i capi sono tornati a casa.
Dopo una decade i Dogo non vestono i panni di nessun altro, ma non sono mai stati così sé stessi: le leggende del rap italiano. Il disco è una lezione ex catedra di rap, per dimostrare di non avere più niente da dimostrare, di avere inventato questo genere in Italia e di averlo fatto come nessuno prima e dopo di loro.
Il tema ripercorre l’intera tracklist, insinuandosi ovunque. In “Mafia del Boom Bap”, Guè “rima da quando i rapper si vestivano da rapper” e Jake “non rappa come questi neanche se avessi un ictus”, opponendosi a quello che il genere è diventato nel corso della loro assenza: i Dogo hanno lasciato un HipHop che sbirciava intimidito le classifiche, facendosi largo tra il pop italiano, e lo ritrovano come il nuovo Mainstream. Il trio tira una linea: da un lato c’è chi il rap l’ha fatto quando era la controcultura, dall’altro c’è chi si è attaccato al carro del vincitore.
I Dogo sono rimasti fedele alla loro bandiera, e l’album “Club Dogo” si riallaccia alla strada. Dico “riallaccia”, perché sembra che con questo disco il trio abbia assolto la propria casa dei fantasmi, abbandonando i colori patinati degli ultimi album, il rosso di “Non siamo quelli di Mi Fist”. La crudezza della street life, la violenza del cemento, della città che schiaccia e che impone la lotta per la vita è il filo conduttore di tutto il progetto. Te lo racconta Guè, in “In Sbatti”:
Svezzato (Ah) dai lupi, la strada ha apprezzato (Yeah)
Club Dogo – In Sbatti (Club Dogo, 2024)
Quanti rapper che ho fezzato (Quanti?), cuori che ho spezzato (Ah)
Canne che ho smezzato (Ah), pezzi che ho piazzato (Uh)
Mentre un bimbo è battezzato (Ah-ah), un uomo è ammazzato (Pah, pah, pah)
Milano è qui, la Gotham City, la città del peccato e della perdizione, quella delle mille contraddizioni: la cocaina di chi non riesce ad arrivare a fine mese è la stessa dei businessmen della Milano Bene, dei DjSet, dei vertici in cui tutto è concesso.
I Dogo parlano Milano e la città parla i Dogo, quasi come se l’una non potesse esistere senza l’altra, come se la città fosse nata dai versi del gruppo tanto quanto il cane argentino sia nato nelle viscere della capitale meneghina. Lo dice Guè in “Malafede”:
Non ho un flow della Madonna ma un flow della Madonnina (Uh)
Club Dogo – Malafede (Club Dogo, 2024)
Se Milano è nel mio cuore, la strada è la mia sore’
Quando lo hai capito? Chi sono le tre teste del Dogo 10 anni dopo? Io avevo paura. Paura che fossero cambiate troppo cose, che i tre avessero preso tre percorsi artistici troppo diversi.
In questi dieci anni Guè è riuscito a costruirsi un’individualità solista incredibile, tale da essere percepito come il migliore di sempre. Il suo personaggio si è così tanto definito, dal lifestyle ai commenti sui social, da farlo diventare troppo ingombrante per farlo entrare in un progetto a sei mani. Nei suoi ultimi dischi si era ritratto sempre di più come un gangster al tramonto, tra la divinità e il fallimento, con una scrittura sempre più carica, sia quando affogava in soldi, droga e successo, sia quando annegava nelle ombre più profonde della sua depressione.
Dall’altro lato, sembrava che Jake non fosse mai riuscito a tornare ai fasti dei tempi che furono, sia in “17” che in “il Ferro del Mestiere”, aveva sempre lasciato qualcuno scontento, come se non bastasse da solo a soddisfare il suo pubblico.
Don Joe, invece, con “Milano Soprano” si era portato tanto amaro in bocca, la sensazione di un’occasione sprecata. Troppe divergenze, troppa acqua sotto il ponte.
Alla fine, non è andato niente storto. I tre si sono amalgamati alla perfezione e “Club Dogo” sembra esserci sempre stato, come se da dieci anni fosse lì, a raccontarsi. Lungi da noi dire che siamo di fronte ad un disco perfetto, in alcuni punti gli equilibri stridono e in alcune tracce sembra che qualcosa venga meno, soprattutto nel finale: “Frate” e “Indelebili” sembrano essere un explicit che non rende giustizia all’epicità dell’intro. Soprattutto nell’outro (ma forse anche in “Tu non sei lei”), La Furia e il Guercio non sembrano armonizzarsi al meglio e dove l’uno sale, l’altro non riesce sempre a giocare alla pari.
Il disco nel suo concludersi lascia un senso di sospensione, come se si sarebbe potuto arrivare ad una conclusione più precisa. Così l’album “Club Dogo” ci parla del cerbero in 35 minuti: una durata che vuole essere live – friendly, che possa lasciare ai concerti lo spazio per tutto il vecchio repertorio.
Il ritorno dei Dogo viene sottolineato ad ogni barra. Il disco è pervaso da una fittissima trama di citazioni, intertestuali e intratestuali: Jake, Guè e Jo citano e si citano costantemente, costringendo l’ascoltatore a mandare la traccia indietro tre volte prima di continuare, per cogliere quanti più riferimenti possibili al passato.
L’intro di “In Sbatti” riprende “D.O.G.O” di “Penna Capitale”, in “Milly” Guè cita “Vida Loca” da “Mi Fist” e nello stesso brano Sfera cita “Il Mio Mondo le Mie Regole” nella sua strofa; in “Tu non sei lei” il Guercio richiama la “Dogodrama Intro” da “Benvenuti nella Giungla” della Dogo Gang: questi sono alcuni dei riferimenti che Guè e Jake si scambiano nelle 380 barre totali dell’LP.
Don Joe, invece? Forse la sua reference è quella più iconica. Quando King of The Jungle suona, la testa comincia ad ondeggiare. Sulle note di un beat reggae il ricordo vola al 2004, a quello storytelling all’ultimo respiro, una rapina finita male, una storia d’amore che nasce in una cella, l’evasione forsennata. Poi sull’outro arriva: il brano si chiude con il ritornello di Note Killer.
Non c’è altro da aggiungere. Questo beat, come tutto il lavoro di Joe, conferma l’idea che l’ultimo progetto porta esattamente il nome del gruppo, senza sovrastrutture o narrazioni altre. Don stende i beat come se fosse un sarto che cuce su misura abiti per modelli di cui conosce a memoria le forme, le curve, le sinuosità e gli angoli.
“Club Dogo” è oscuro, cupo, terribilmente boom bap e classico: suona Dogo in ogni kick, snare e cassa, lontano dai piattini e dalle melodie della trap, trasuda campionamenti, da Nada in “Malafede” a 50 Cent in “Nati per questo”. La Gotham del Club, parte dalle atmosfere e dai suoni, senza colori, avvolta nell’oscurità: Jake e Guè sono i suoi eroi.
Potremmo a lungo parlare dei featuring, litigare per definire se siano appropriati o meno. Resta l’amaro in bocca per chi si aspettava il ritorno dell’intera Dogo Gang, magari con un contributo di Enz Benz o di Vincenzo, ma non è stato così. Il ritorno dei Dogo si associa solo a tre nomi, tre ospiti e nient’altro: Marracash, Sfera, Elodie, ognuno accolto nel suo elemento.
Marra ci regala forse una delle sue migliori strofe in “Nato per Questo”, Sfera aggiunge la trap a “Milly” e Elodie ci regala un elegante e notturno ritornello in “Soli a Milano”. Ognuno al meglio delle proprie capacità: i Dogo chiamano tre sovrani indiscussi del genere, il king del rap, il re del trap e la regina dell’urban pop quasi come se volessero dimostrare la loro versatilità, l’essere in grado di fondersi alla perfezione con le tre massime tendenze musicali del nostro panorama.
La rivoluzione è tornata e imperversa per le strada: bandiere nere si gonfiano al vento, le casse fanno tremare i palazzi. Lasciati attraversare, sia che tu la stia aspettando da dieci lunghi anni, sia che tu sia qui da pochi mesi. Guardati intorno: la gente in strada ha ancora i tattoo del cane sulle braccia. Club Dogo è per me che ho scritto questo articolo, per te che lo hai letto. I Club Dogo sono tornati. Per tutti. Per la gente.
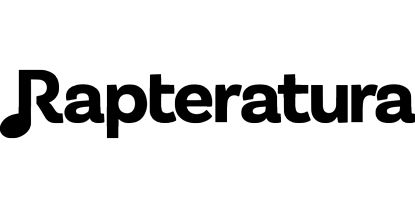







Nessun commento!