Se c’è una parola che può raccontare questo 2025 (e il ponte sullo stretto che stiamo costruendo verso il 2026) è ritorno. “Ritorno al futuro”, alla storia, ritorno alle radici, ritorno a forme riconoscibili, rassicuranti, spesso già viste; una specie di conservatorismo remixato, una nostalgia che passa attraverso il filtro dell’estetica vintage con un tantino di quel filler adatto ai social.
Nostalgia, antichi fasti contro presente decadente: ne abbiamo parlato tra il 2023 e il 2024 con il “biennio viola” e poi tra il 2024 e il 2025, di come le uscite del rap italiano possano essere paragonabili al catalogo Netflix; questa volta per provare a capire le tendenze del 2026 penso che sia ancora una volta necessario incrociare lo sguardo minaccioso e le movenze imperialiste di “mamma America” per provare a capire come – almeno dal punto di vista musicale – ne risentiremo noi.
Mi perdoni chi appartiene al mondo delle scienze sociali per le mie affermazioni, ma l’impressione che ho è che l’attuale sistema culturale funziona sempre più come un archivio. Non inventa, seleziona. Non rompe, riprogramma; le Nike Shox delle mie scuole medie ritornano sul mercato con qualche molla in più, leggermente meno resistenti e molto più costose. E in questo senso il rap non fa eccezione, anzi: è uno dei campi dove questo processo è più evidente.
Ripartiamo un attimo dal 2024.
2024, quando Kendrick Lamar e Drake hanno riaperto il “sottosopra”
Dicono che il gioco sia bello quando dura poco e che i dissing fanno parte del gioco, ma stavolta, per quanto i dissing possano essere eventi di spettacolo, non è stato solo intrattenimento e ha distorto le pieghe spazio-temporali.
Lo scontro tra K.Dot e Drake ha brutalizzato il paesaggio: ha aperto nel terreno un varco così profondo da distruggere lo strato di crosta terrestre e mettere a nudo una parte di mantello in cui scorre il magma vivo della culture e innescando una serie di conseguenze.
La faida tra i due la racconta alla perfezione Frazier Tharpe su GQ USA, per noi l’hanno tradotta alla grande Antonio Buonocore e Francesco Menichella in questo articolo, mi limiterò a citare la diss-track che mi permette di salire sul trampolino adatto ad effettuare il mio semi-volo pindarico.
In “Euphoria“, Kendrick fa un chiaro riferimento alla serie prodotta da Drake e si concentra su come Drake possa rivedersi nei protagonisti alto-borghesi del telefilm, differentemente da Kendrick, che viene dall’esatto contesto opposto.
Tralasciando gli incredibili beatswitch – in forte incremento anche in Italia dopo questo scontro tra titani, Kendrick accende i fari sul personaggio-Drake (aspetti contrattuali, compromessi, ghost writing) con la volontà di illuminarlo, come nel mito della caverna platonica, con la lanterna della cultura.
In questo brano K.dot Accusa Drake di non avere rispetto per la comunità di rapper che rappresentano i veri valori, di essere solo un passeggero della culture, un “culture vulture” (lett. avvoltoio della cultura) che si serve degli espedienti narrativi del rap (armi, droghe, spaccio ecc) senza avere una stazza realmente adatta a sostenere il peso di quanto detto in un microfono che, per poter avere forza, si serve di un’intelligenza artificiale pronta a resuscitare e far parlare gli avi del genere (es. Tupac) pur di dare significato alle sue parole.
Senza addentrarmi nella questione etnica dell’essere mixed, Kendrick sostiene che tutto ciò che ha spiattellato nei 6 minuti di traccia sono tutti buoni motivi per revocargli l’n-word; Kendrick si erge a censore della black culture, come se il popolo nero stesso lo avesse incaricato. Parole molto forti, che per ovvi motivi non riusciamo a comprendere fino in fondo, ma che mostrano quanto anche negli avamposti del genere ci siano dei principi su cui dibattere.
Sì, il colpo di grazia è stato “Not Like Us”, un inno virale: Kendrick Lamar – per la critica – ne è uscito vincitore, tenendo sempre le redini della narrativa e costruendone i binari, Drake ha subito il contraccolpo in termini di credibilità, ma le sue vendite sono rimaste piuttosto costanti.
Il beef è diventato subito l’istantanea delle due visioni dell’hip-hop ai lati dell’ellisse, incapaci di dialogare ma in grado di tenere in piedi tutto l’ambaradan: arte e identità culturale vs intrattenimento e consumo.
Lo scontro ha inoltre tracciato i contorni etici del genere: i super-record di Drake si fanno simbolo della produzione in serie della musica che vuole parlare a nessuno escluso, i brani di Kendrick Lamar sono il tentativo di recuperare il valore collettivo di un genere profondamente legato ad un’ideologia.
Tra le cose più preziose che però ci portiamo dietro è che questo genere musicale ha vita propria.
Davanti a questioni dicotomiche, fatte di apparente bianco e nero, di bene e male, il rap non smette di interrogarsi, di ragionare su sé stesso e di dare risposte come ogni prodotto artisticamente denso; ecco che l’album “We Don’t Trust You” (2024) di Future e Metro diventa una replica a questa polemica pronta a ri-configurare i confini della trap in maniera totalmente USA, dall’altra “GNX” re-invita alle origini ma senza mostrarsi superbo e museale, rimanendo la voce del popolo tra il popolo.
Come sostiene anche Emilio Zucchetti – un nostro prezioso lettore che ha ispirato questa riflessione – sotto un nostro post, Drake incarna un vero e proprio colonialismo musicale: estrattivismo che omologa tutto – afro, latin, trap, drill – per targetizzare pubblici diversi, svuotando di significato ogni riferimento culturale. È il capitalismo svestito che trasforma il rap in intrattenimento universale, togliendolo alla sua comunità di riferimento, diventando edulcorato, pacifico, lovely.
I due modelli punta-dell-iceberg del mercato mainstream, il modello-Drake e il modello-Kendrick-Lamar, sono entrati in aperto contrasto e hanno mostrato al mondo intero la contraddittorietà latente che porta con sé; la carica controculturale del rap si è smussata, normalizzata, è diventata un accessorio simbolico da sfoggiare mentre l’identità del genere sta cercando di divincolarsi dentro a delle etichette scomode affibbiate dal pubblico.
L’aura che ha ammantato i due artisti negli eventi dal vivo, anche quando sono venuti in Italia, è stata abbastanza rivelatrice: da una parte c’era chi vedeva Kendrick come un salvatore, dall’altra chi voleva Drake sul rogo, perdendo forse di vista il fatto che, come detto, sono due espressioni del medesimo genere, altrettanto legittime, ma che però mostrano due facce distanti, inconciliabili, della cultura americana tutta.
Il grande parapiglia mediatico che i due – qui presi in considerazione soprattutto come macroesempi – hanno generato porta a galla la domanda amletica più prevedibile ma forse più necessaria: quale strada intraprendere? L’una esclude l’altra?
I due testimoni discografici non trovano riscontro in quella che sarebbe potuta essere la generazione successiva a portare il testimone del processo dialettico storico; la cosiddetta generazione 21 – Juice WRLD, Lil Peep, XXXTentacion, Pop Smoke – è morta prima di poter diventare davvero classe dirigente e rimescolare ancora le carte.
Sia chiaro, di nuovi artisti e artiste capaci di cambiare i destini generali del genere ce ce ne sono, ma i modelli principali del mercato, quelli esportabili di stato in stato, per riavere “l’equivalente culturale” in casa propria, se ben incarnati, si respingono.
Il disorientamento discografico, del pubblico e le domande del genere, hanno trovato una risposta nostalgica che ha una forte ragion d’essere. Parlo del ritorno dei Clipse, ma andiamo con ordine.
… cacciando il rap dalle Classifiche Billboard 2025. Una delle risposte?
Cosa succede nel 2025? Il rap dopo 35 anni esce dalle classifiche Billboard. Quindi il genere sta morendo? Assolutamente no, Giordano in questo post lo spiega efficacemente e molto più brevemente di quanto avrei fatto io.
Il modello-Drake-capitalista ora è in crisi. La storia ci ha insegnato che davanti alle rivoluzioni tecnologiche e agli empasse dell’industria la risposta diventa l’imperialismo, ma adesso che la grande macchina dell’industria si trova in difficoltà, la risposta prova a cercarla in casa sua, proprio da chi alla CULTURE ha contribuito; “Let Get Sort Em Out” dei Clipse, che Franco e Mir hanno recensito alla grande, risponde a tanti interrogativi anche senza rispondere.
Questo disco, al netto del valore musicale, è soprattutto un manifesto politico-culturale, perché tra coke rap e criminalità ridiscute ancora una volta il “perché farlo” e tocca il nervo del “culturalmente inappropriato“. Non nel senso moralista o da policing social, ma nel senso originario e materiale del termine: chi ha il diritto di usare certi codici, certe storie, certe estetiche, e a che prezzo.
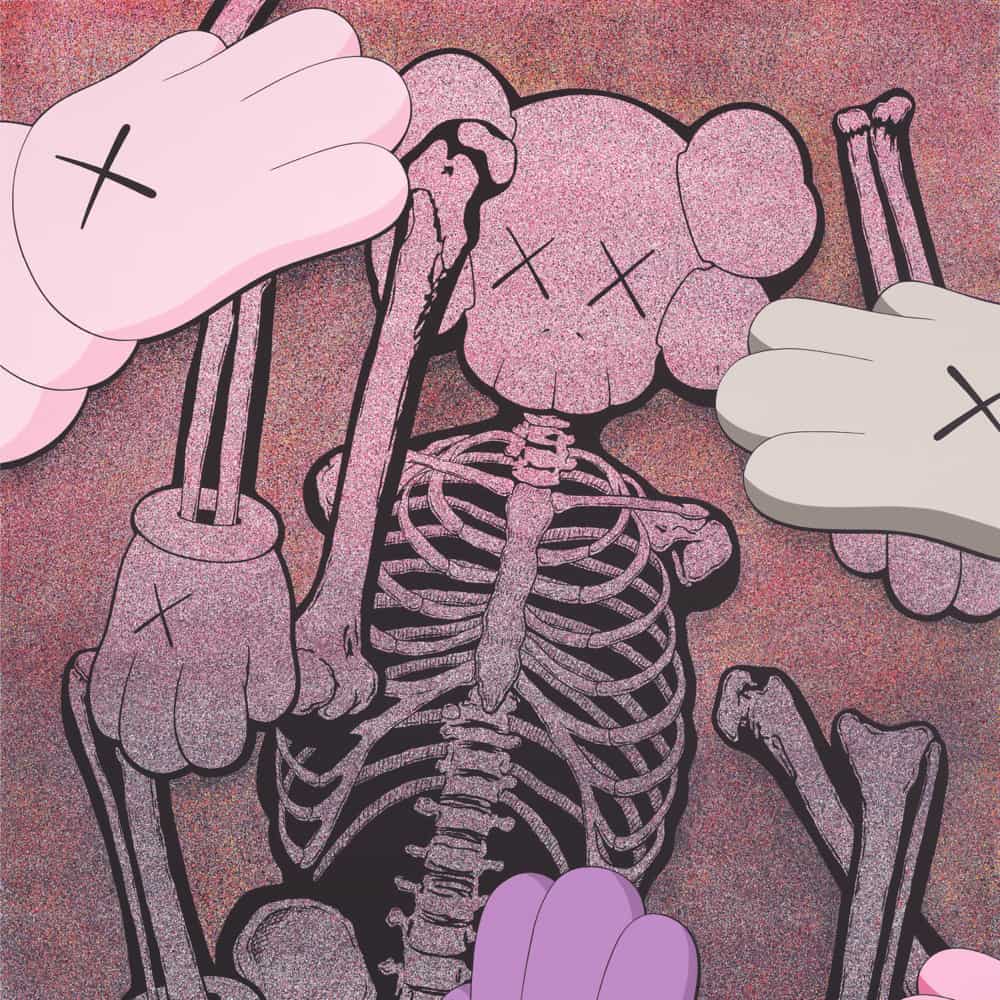
Il sample che ritorna per ben 14 volte (“this is culturally inappropriate”) non solo ammonisce sulla natura del progetto ma funziona ambiguamente su più livelli. I Clipse, dopo una separazione che ha portato un lunghissimo peregrinare, parlano dalla posizione di chi ha visto questa musica diventare prima linguaggio globale e poi prodotto da esportazione.
Il punto non è “non puoi farlo”, ma “non puoi farlo solo svuotandolo”. Ed è qui che il concetto di “culturalmente inappropriato” smette di essere una questione etica astratta e diventa una questione economica e simbolica.
A mio parere, nel disco il bersaglio non è solo Drake come individuo o – come si pensava in quel momento – A$AP Rocky, ma l’intero sistema che i rapper superstar incarnano: un modello di artista che attraversa culture diverse come fossero preset, prendendo ciò che funziona e lasciando fuori ciò che pesa.
Il risultato è una musica perfettamente adattabile, universale, ma proprio per questo senza attrito, senza conflitto, senza responsabilità verso il contesto che l’ha generata.
Su “Chains & Whips” Pusha T dice
Uncle said, “Nigga, you must be sick
Clipse – Chains & Whips (Let Get Sort ‘Em Out, 2025)
All you talk about is just gettin’ rich”
Choke my neck, nigga, and ice my bitch
Beat the system with chains and whips
This is culturally inappropriate
I Clipse si collocano volutamente fuori dal perimetro del “rap accettabile”, quello che può essere globalizzato, universalizzato, ripulito. E non è un caso che questa etichetta ritorni soprattutto nei brani che coinvolgono proprio Kendrick Lamar, Nas, Ab-Liva: artisti che hanno sempre rappresentato una frizione, un attrito, non una sintesi pacifica.
I Clipse ci stanno dicendo che non sono traducibili, che stanno usando tutto quello che vogliono loro (dai campioni alla coc*ina) come arma simbolica per rimettere il conflitto al centro. Loro non vogliono rappresentare nessuno se non sé stessi, assumendosi il rischio di risultare scomodi, incomprensibili, non allineati e non sempre primi in classifica. In due parole: non integrati.
Questa è la terza via che il mercato mainstream del rap ci offre, ma non punta sicuramente alle classifiche Billboard. Le storie di Denzel Curry, di qualche tempo fa, molto più sinteticamente, dicono quanto ho detto fino ad adesso; questo un po’ mi rincuora.
Quindi l’industria come risponde?
Vendere, vendere, simpaticamente il tradizionale “caso Taylor Swift-Stranger Things”
Vendere, vendere e vendere. Se non si massimizza il profitto con la musica che glorifica anche il profitto, allora torniamo su ciò che c’è di più rassicurante.
Diventano due facce complementari della stessa locomotiva che sfreccia senza sosta una delle più grandi popstar mondiali e la serie evento della nota piattaforma streaming; lo chiameremo per comodità “caso Taylor Swift-Stranger Things“.
Il 3 ottobre 2025, Taylor Swift ha pubblicato il suo dodicesimo album, “The Life of a Showgirl” ottenendo un enorme successo internazionale. Il disco di Swift è diventato disco d’oro in Italia in una settimana e ha segnato il miglior debutto del 2025 per un artista internazionale nel nostro paese.
L’artista, paladina dei diritti, progressista e indipendente, in questo album dal sapore country family friendly sceglie di raccontare una versione inedita di sé: una donna che grazie all’amore di suo marito trova il posto nel mondo, capisce che il suo vero sogno è sposarsi, avere una famiglia felice e vivere in un quartiere sicuro, all’altezza delle sue aspettative e idoneo al suo modus vivendi.
Quindi “The Life Of a Showgirl” è l’illuminazione sulla via di Damasco o una risposta confortante data dagli Stati Uniti (al mondo) che stanno smarrendo “i veri valori” in linea con la macchina della propaganda dell’aquila?
Davanti alle guerre che imperano, ad un Occidente che fa fatica a reggersi su stesso, l’ultimo disco di Taylor Swift non è solo un evento pop che distoglie per un attimo l’attenzione dal putiferio, ma un altro segnale fortissimo di questa spinta conservatrice che punta a riprendere ciò che già c’è e funzionava: un ritorno a forme riconoscibili, alla narrazione personale come mito, alla comfort zone elevata a valore culturale.
Non è nostalgia passiva, è l’ennesimo caso, questa volta conclamato, di nostalgia creata in provetta come un vero e proprio progetto di ingegneria industriale.
Fuori dalla musica? “Stranger Things” è l’esempio perfetto.
Proprio alle soglie della clamorosa acquisizione di Warner Bros da parte di Netflix, il primo prodotto streaming reso forzosamente di massa che vive di hit del passato, rispolvera le tensioni USA-URSS e rimette in scena un immaginario sì tetro ma rassicurante, indicando chiaramente quali sono “i valori giusti” da tenere saldi. Vintage aesthetic puro.
Il primo telefilm streaming massificato, capace di creare ad hoc una memoria collettiva, crea ricordi nuovi riportando in cima alle classifiche prima “Running Up That Hill“, poi aiutato da TikTok “End Of Beginning” e il catalogo di Prince; mettendo il brano al momento giusto, nel picco di maggior pathos, scatenando un bellissimo incontro generazionale tra nuove scoperte per i più giovani e vecchi e bei ricordi per i più adulti.
Quando? Proprio quando le persone sono tendenzialmente più a casa. Durante le vacanze Natalizie, dove si riscoprono i valori della “famiglia”, del gruppo di amici e amiche, di, quando – dopo le compere, i regali, i cenoni e i pranzoni – ci si mette sul divano con chi vuoi tu, nel chill, e premi play per rilassarti. In una dimensione coccolante, che conosci, che ti dà sicurezza. Non quella del presente, quella del presente travestito da passato.
E il rap italiano? Ha un modello prevalente.
Credo che, ad inizio 2026, nonostante tutti gli annunci imminenti, sia simile a quella d’inizio 2025, con una crescita smisurata (ma non imprevedibile) di Anna, un miglioramento del rap declinato al femminile (complici le ottimissime prestazioni di Ele A) e l’emersione dei Players ’25.
Se le vecchie leve mantengono uno smalto invidiabile, a dover mettere i mattoni decisivi restano ancora i Players ’23: Nerissima Serpe, Artie 5ive, Tony Boy, Papa V, Low-Red, Digital Astro e Kid Yugi.
Se per Artie 5ive, visto l’anno da incorniciare con “LA BELLAVITA”, e Tony Boy, va fatto un discorso a parte sulle loro carriere soliste, per tutto quanto il gruppo mi sento di parlare di stasi: ad ogni rapper in questione possiamo associare un mini trend da TikTok, un’attitudine con diversi tipi di gradazione e una strofa-tipo solo a leggere il loro nome in una collaborazione.
Da una parte rende lode alla creazione d’identità che stanno portando avanti, dall’altra dimostra quanto stiano crescendo come altri rapper-stereotipo da vendere o rapper-figurine da appiccicare in un disco come ornamenti: se leggi Tony Boy sai che la strofa potrà andare dall’introflessione fino alla ricerca del banger, se trovi Papa e Neri sai che puoi aspettarti “la linea comica” o ruvide parti introspettive, se leggi Kid Yugi sai che troverai o una strofa filo-intellettuale o fortemente street con qualche parola non frequente nei frasari dei rapper e via dicendo.
Questo sistema, che trova pieno appoggio dai nomi più storici, sta creando un ulteriore spazio per i Players ’25 (Glocky, RRARI DAL TACCO, Promessa, Latrelle, Ele A, Sayf, Melons) che nel giro di un anno, si sono ritrovati nei tavoli dei grandi: dalle collaborazioni di Marracash con 22simba, alla collaborazione già annunciata di Latrelle con Tedua, da Guè con molti di loro, alla super coppia Guè-Ele A, a Sayf già catapultato a Sanremo 2026 dopo (sì, va bene, 7 anni di gavetta) una collaborazione estiva incredibilmente inconsistente con Marco Mengoni e Rkomi.

“Il professionista gioca sempre su più tavoli” diceva Marra, ma quanta pressione si sta esercitando su tutta la scena e i nuovi prescelti? I nuovi rampolli sono indubbiamente capaci, ma l’impressione è che ci sia un rincalzo pronto prima ancora che la generazione precedente finisca di sbocciare. Una scena che accelera così tanto rischia di non sedimentare nulla. Si sta costruendo o solo sostituendo?
Un po’ come nel calcio: ci sono tante partite da guardare (forse troppe?) e mentre Mbappé eguaglia i record di Ronaldo, la nuova generazione rischia di replicare la precedente senza superarla davvero.
E la musica da ascoltare? Quanta ne sta diventando? Ma soprattutto, se hai seguito il mio estenuante ragionamento fino a qui (grazie di cuore), puoi rinvenire tanti modello-Drake ma quanti modello-Kendrick o modello-Clipse ritrovi?
C’è qualcuno che ha ancora intenzione di dialogare con la culture? Fortunatamente sì, perché abbiamo avuto “60 HZ II” di Shocca che ha messo d’accordo (quasi) tutti e “Manifesto” di Shablo che ha fatto un’importante azione di selezione, proposta e stimolo. Dietro a loro si colloca l’instancabile Gué, ma pochi altri tra i big sono quelli pronti ad aprire un dialogo per dare qualcosa in più alla cultura del genere.
Le alternative non ancora iper-vendibili
In tutto ciò, se si esclude la dimensione live altamente scadente – ma di questo me ne sono già lamentato -, ci sono artisti che hanno saputo ben interpretare il cambio aura del genere; sì, la distanza artista-pubblico si sta accorciando ancor di più, ma se da una parte produce prodotti omologati, dall’altra resistono nuove configurazioni che rimettono al centro l’esperienza quotidiana atipica; “faccio dormire un mio fan a casa se non c’è il treno” (18K – UPPDOWN, 2025).
Mi riferisco a 18K, Visino Bianco, Macello – ai loro live, in cui si respira ancora un po’ di vecchia e sana tribalità, tanta connessione e originalità -, ad Armani Doc, Toni Zeno, Hammon, Glasond, Aira, SKT e molti altri rapper che vogliono mantenere la loro definizione di autenticità al centro di tutto.
Quelli citati qui ancora non hanno raggiunto l’appeal di vendita di quelli nominati sopra, proprio per questo riescono ancora a mantenere un contatto autentico fatto di cura del loro prodotto, ma con le “imperfezioni” che lo rendono ancora autentico.
e la risposta tradizionale.
Il grande ritorno vendibile invece prende il nome di cantautorato. Nella nostra fattispecie un cantautorato-rap che diventa la risposta nazionale alla spinta conservatrice globale. Non perché le nuove generazioni non abbiano nulla da dire, ma perché il sistema non sembra disposto a rischiare davvero su di loro.
La direzione di Sanremo di Carlo Conti, quella post-Amadeus, in linea con i dictamen del momento storico, parla chiaro: rimettere la canzone al centro. Ecco qui che si rinforza Achille Lauro, ecco qui che vince Olly, ecco qui Lucio Corsi ed ecco qui spiegate le molte scelte degli artisti del 2026.
Gli artisti portati in gara sono i più “cantautorabili”, i più leggibili, i più compatibili con una narrazione nazionale. L’ibrido “che piace ai giovani”, soprattutto a chi non piace il rap, e risponde a tutte queste richieste è una specie di “cantautorap” che vede come interpreti artisti del calibro di Rancore, Murubutu, Caparezza, ma per il palco di Sanremo risponde ad un solo nome: nayt. L’artista, coerentemente con il suo percorso, risponde rimanendo innovativo e tradizionale allo stesso tempo, senza urtare nessuno.
Abbiamo almeno tre esempi di interpretare oggi la canzone d’autore nel rap italiano: c’è chi tiene il piede in due scarpe (Ernia, Geolier, Lazza, fino a una certo Marra), c’è Guè, che resta trendsetter ma parla soprattutto a chi mastica davvero hip hop, e poi c’è un underground che spesso è più vitale del mainstream e ci regala gli esperimenti più interessanti. Non è un caso che escluso l’underground, queste categorie siano passate, sotto formule diverse, a Sanremo.
E nell’underground, le figure che dialogano con la culture sono molte più di quanto pensiamo, ma i nostri riflettori non sono abbastanza forti per dar loro la giusta luce; continueremo a portare avanti, con impegno, questa idea.
Proprio come ha fatto ben capire il nostro Fra Rapuano in questo articolo – che ringrazio apertamente, ha ispirato gran parte del lavoro – , il rap ibridato con il cantautorato diventa la risposta forse più democristiana, ma allo stesso tempo più credibile nel nostro panorama.
Non credo nemmeno sia un caso che, proprio come “Stranger Things“, questi brani passino attraverso un programma a più appuntamenti, ritualizzato, che necessita del tepore della compagnia, del consumo, del chill, in una dimensione coccolante, casalinga, che ti dà sicurezza. Non quella del presente, quella del presente travestito da passato, quella del Festival di Sanremo.
Conclusioni, penserai finalmente
A mio parere, ogni nazione risponde al conservatorismo culturale a modo suo. L’America con il mito della comunità e il conflitto interno al rap, l’Italia con il rifugio nel cantautorato. In mezzo, un sistema che guarda sempre più al passato per immaginare il futuro.
La domanda, forse, è una sola: questo ritorno è una fase di transizione o il segno che abbiamo smesso di credere davvero nella possibilità di qualcosa di nuovo?
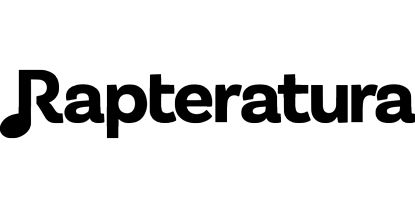







Nessun commento!