Tra rap e letteratura: INFERNVM di Murubutu e Claver Gold
Nel campo di Monowitz, Primo Levi sta andando a recuperare il pranzo per la propria squadra di lavoro; lo accompagna il “Pikolo” Jean Samuel, un giovane francese di Strasburgo. Durante il tragitto, decide di insegnargli la sua lingua: per farlo, comincia a recitare alcune terzine della Divina Commedia e, celermente, ne improvvisa una traduzione nella lingua d’oltralpe. Non è un caso che i versi riportati alla mente provengano dal XXVI canto, il canto d’Ulisse. Nel girone infernale di Auschwitz, risuona uno strano invito alla virtù e alla conoscenza, contro l’inutile e illogico male che fa il suo corso nei campi. Il messaggio è chiaro: nel luogo della morte, la cultura e l’azzardo odissiaco del sapere possono essere luogo di vita e di incontro di esistenze.
Di conseguenza, potremmo facilmente affermare che “INFERNVM” vuole essere, parimenti, la risposta della cultura e del passato a un presente illogicamente malvagio; potremmo asserire che in INFERNVM Murubutu e Claver Gold hanno offerto un antidoto al virus, in cui ritrovare la vita; potremmo ancora concludere che il loro è un (socratico) stimolo al sapere e alla (schilleriana) “educazione estetica”, in un tempo che ha smarrito entrambi; o, infine, concordare con loro quando affermano che intento dell’album è quello di “leggere la realtà attuale, che per alcune persone è un inferno” (in un’intervista rilasciata per “La casa del rap”). Tuttavia, diremo di più: vogliamo credere che per loro la cultura non sia una risposta, ma piuttosto un’affermazione, la cui validità universale e onnitemporale sta entro i propri stessi confini.
Rapportarsi a un’opera dalla mole immensa e tentare di re-interpretarla, quando una storia della sua critica e delle sue re-interpretazioni ha già fatto ampiamente il suo corso, è cosa arditissima. Ci immaginiamo i due ridere di sé, dopo aver proposto un’impresa tanto grande e folle (nel realizzare INFERNVM Murubutu ebbe remore, alla prima proposta di Claver). Al cospetto del Sommo, tutti pagano il fio della loro condizione di epigoni, ermeneuti, lettori e – al massimo – eruditi. Eppure, il progetto è l’ennesima dimostrazione che la cultura non è scherzo di eruditi, non è ripiegamento su se stessa, bensì è “slancio vitale”, ciclica rigenerazione di se stessa, propulsione creativa sempre in atto.
La grandezza dell’album – uscito il 31 marzo per la storica collaboratrice Glory Hole Records – sta nell’aver sapientemente equilibrato le due vesti con cui un lettore acuto può presentarsi al cospetto dell’autore: l’abito dell’ossequio e quello dell’emulazione. Il reggiano e l’ascolano hanno azzardato nuovamente il viaggio dantesco e, con straordinaria lucidità, sono stati in grado di “superare conservando” (per citare un altro grande), dando una veste contemporanea a un monumento che è già di per sé perennemente attuale. Nell’abisso dell’azzardo, come Ulisse, hanno portato con sé un equipaggio altrettanto coraggioso: dall’esperienza degli amici Dj Fastcut e Il Tenente alle voci cantautorali di Davide Shorty e Giuliano Palma. Il primo concept album collaborativo di Alessio Mariani e Daycol Orsini è l’incontro di due delle migliori penne che abbiamo in Italia in un progetto prodigioso che riesce a consacrare Dante dandogli nuova vita, senza peccare della pedanteria dell’erudito né dell’arroganza dell’ingenuo. Il tessuto musicale riesce a dare godibilità e scorrevolezza ai cupi suoni dell’inferno, attraverso una ricerca già sperimentata in lavori precedenti da parte di entrambi. Il cammino, che comincia il 25 marzo come quello di Dante e contiene undici tracce dalla durata media di 3’ ciascuna (non a caso), è una evocazione suggestiva e tremenda, simile a quella della maga Erittò: di uomini, di drammi, di colpe e pentimenti, di pene. A guisa del soldato morto chiamato dalla strega a profetizzare a Pompeo l’imminente strage (nella Pharsalia di Lucano), le voci dei dannati salgono alle terre di sopra per ammonire i vivi dai vizi ed esortarli alla virtù, godendo un presente che non è più loro possibile.
Consapevoli che un’analisi delle singole tracce sarebbe operazione immane e, per di più, violerebbe la densità di questo lavoro per esigenze di sintesi, proponiamo una breve analisi di tre punti, lasciando a voi di essere suggestionati da un primo ascolto e portati d’incanto nelle regioni buie.
L’intro e l’outro, ovvero i suoni dell’Inferno.
- “Selva Oscura” è il prezzo che Murubutu e Claver devono pagare al loro esser lettori: un gioco di citazioni sapientemente distribuito introduce l’ascoltatore al viaggio tremendo, situandolo in un’atmosfera già cupa e infernale. All’eccellente voce baritonale di Vincenzo di Bonaventura rispondono fischi, grida lontane, urla di disperazione che quasi materialmente si concretano davanti a noi; i bassi colpiscono sordi e cadenzati a dire la ciclicità instancabile delle pene, le note gravi di piano a pronunciare solennità e severità, gli archi a evocare la lontana sinfonia dei cieli del Paradiso. “Chiaro mondo” (citazione dal canto XXXIV, che chiude la cantica) è il colpo di genio, la piccola libertà di cui non hanno saputo privarsi il Virgilio e il Dante della nostra storia: se il giro di note ancora cupo percorso da quello che pare essere un violoncello è, come nell’intro, rotto da saltuarie grida di dolore (a suggerire un sipario che i due chiudono dietro di sé), cambia radicalmente il gioco delle citazioni, ora indirizzato a brani dei due artisti (rispettivamente a “La Murubeide” di Murubutu e a “La cicala” di Claver). Una svolta che potrebbe far storcere il naso agli italianisti e ai puristi (gli stessi che all’ascolto del disco opporrebbero un secco rifiuto), ma che abbiamo apprezzato nella sua sregolatezza.
“Caronte”, ovvero il trasporto.
- Trasporto con duplice significato: trasporto sul “legno del demone guida” che porti al di là dell’Acheronte e al Giudizio; trasporto dei sensi di “un passeggero in fuga verso il nuovo regno”, in cerca di un’avventura al di là del proprio corpo perché la sua vita non lo soddisfa. “Di traversare il fiume nero e poi scordare l’ero”: esplicita è l’allusione agli stupefacenti pesanti che in troppi assumono per aprire alla Baudelaire quei “Paradisi artificiali” (qui Inferni) in cui inabissare la propria coscienza. La lezione “morale” dei due lascia però il passo in questo brano a un affresco vividissimo della traversata infernale: il vecchio nocchiero “d’antico pelo, pieno d’astio” che percuote i dannati, “fiero” sul suo legno; le anime incorporee dei dannati che si ammassano sulla riva mostrando i due oboli per il trasferimento; l’immagine forte del “peso della dannazione”; l’oscillazione del beat, che insegue il muoversi tra le sponde del legno acherontico. A noi che siamo coi dannati e abbiamo con loro la fretta di imbarcarci, suona durissima la constatazione tratta dell’Ecclesiaste “Vanità è storia dell’umanità”: un presente che irrompe nel passato del racconto, trascende i tempi e risuona tremendo accanto a noi (questo è il senso dell’album, in fondo).
“Pier”, ovvero il suicidio.
Sopra una sapiente orchestrazione di termini appartenenti alla flora (sua pena è diventar pianta), il destino di Pier delle Vigne, fido consigliere di Federico II che fa la sua comparsa nel canto XIII, corre parallelo a quello di un suo omonimo dei tempi d’oggi. Entrambi esposti alle vessazioni della Maldicenza e dell’Invidia, decidono in un “autunno di malinconia” di cadere come le foglie, e si danno la morte. L’episodio forse più drammatico dell’intero racconto segna in maniera definitiva l’oscillazione tematica tra l’Inferno di Dante e alcuni inferni in cui oggi molti si trovano a vivere.
Di Marco Palombelli
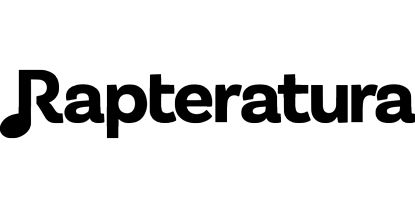







Nessun commento!