“Non sei più quello/a di una volta”. “Non sei più quello di Mi Fist”, commentavano così sotto i video di YouTube i fan nostalgici davanti all’uscita di un nuovo brano o disco che non ricalcava più il gusto a cui erano abituati. “Non Siamo Più Quelli Di Mi Fist” (2014) è invece l’ultimo album dei Club Dogo in cui gli artisti stessi ironizzavano su quel modo di dire che avevano involontariamente fatto coniare.
Ma quanto è difficile accogliere un cambiamento? E sottolineo “accogliere”, perché è completamente diverso da “accettare”. Se accetti qualcosa vuol dire che quel qualcosa lo prendi facendoti andar bene anche i difetti, quasi un “prendere con rassegnazione”, “accogliere” invece vuol dire far anche far entrare così com’è, senza riserve, positivamente, senza sperare che ciò che sta entrando cambi. Più o meno.
Eppure, siamo continuamente esposti al cambiamento. Mentre stai leggendo questo scritto stai respirando aria sempre diversa, il sangue sta scorrendo nel tuo corpo come l’acqua nel letto di un fiume, stai battendo le palpebre e ciò che stai scorrendo con gli occhi sta influenzando, in qualche maniera, il tuo pensiero. Sei una persona diversa rispetto a quella che aveva iniziato a leggere.
Quindi se con il divenire ci scendiamo a patti ogni giorno, in ogni momento, perché è così difficile accettarlo anche nella musica? Cosa ci spinge a dire “non sei più quello di Mi Fist”? Come si è coniata questa espressione? Ma soprattutto è vero che il primo è album è quasi sempre il migliore?
Ogni prodotto artistico che esce è figlio del proprio tempo, ma soprattutto del contesto in cui questo viene pensato e realizzato. Questi due aspetti, il tempo e il contesto, sono imprescindibili per comprendere un’opera e la sua importanza. Ogni volta che, nel nostro caso, un disco esce, c’è un pubblico eterogeneo pronto ad ascoltarlo. Se chi lo compone riesce ad adottare il linguaggio di tutti, tanto da saper cogliere lo Zeitgeist, lo spirito culturale che plasma una determinata epoca, pubblica un album generazionale. Di dischi generazionali ce ne sono tanti e spesso, se uniti, riescono a restituire una parte di quell’identità collettiva di un preciso momento.
Fu questo il caso di “Mi Fist”. Era il 2003 quando il disco venne alla luce e fu in grado di catturare e rappresentare quella Milano di quel tempo, come dice anche il titolo (ndr. il “Mi” sta per “Milano”). Mentre il rap diventava sempre meno frequentato, gli Articolo 31 cercavano di inglobare altri generi, i Club Dogo decidono di rimanere ancorati al rap e di registrare un disco dall’attitudine street su campioni blues capace di fotografare le strade di un’iconica città italiana che, prima di allora, non era stata ancora impressa su un certo tipo di note.
Tolto l’incredibile fascino che possono avere per gli antiquari alcune precise circostanze – come l’aver distribuito il disco a mano, l’aver permesso ai Dogo di iniziare a campare con il rap ecc.-, ciò che ha saputo dare veramente valore al disco, sono state le persone di quel tempo che gli hanno attribuito il significato, rispecchiandosi e trovando dei corrispettivi, e il tempo che è stato lasciato al disco per poter decantare nelle orecchie, nella memoria, sugli scaffali polverosi.
Alcuni dischi, rispetto ad altri, hanno avuto il privilegio di vivere il tempo, di vivere nel tempo, di uscire dai supporti fisici per poter prendere vita nelle casse, nelle serate, agli eventi, sotto ai palchi, nei luoghi fisici dove avviene la comunione di spirito tra ascoltatore e artista, dove si condivide la stessa aria. Questi prodotti, avendo avuto l’opportunità di essere esperiti e di essere stati ottimi accompagnamenti emotivo-sentimentali, scavano la superficie e, modellata la fossa, assumono le fattezze di un contenitore di ricordi.
Questo è un po’ il primo punto di snodo del discorso. Il ricordo. L’etimologia della parola stessa ci fa comprendere la sua potenza. Il verbo “ricordare”, di matrice latina, è composto da “re”, che indica “di nuovo”, il ritornare indietro, è il “cord”, da “cor” che vuol dire “cuore”, l’organo vitale che pulsa sangue ma che, nella cultura latina, si credeva fosse anche sede della memoria. “Ricordare” quindi significa “richiamare alla mente, alla memoria” e porta con sé un’accezione quasi positiva, come se i ricordi, passando per il cuore, facessero bene.
Nel momento in cui un disco riesce a diventare generazionale, segnando un’epoca e catturando il ricordo di molte persone, si porta con sé il pesantissimo fardello di diventare anche un metro di paragone, così come è successo con i Club Dogo, che, come anticipato all’inizio, sono arrivati addirittura a chiamare l’ultimo album “Non Siamo Più Quelli di Mi Fist”, per far capire al pubblico che era ora di accogliere il cambiamento, senza più rimanere ancorati a quello che era stato e non era più.
L’idolatria e il set di uno standard sono alcuni dei contrappassi che portano con sé i primi prodotti, ma questo non accade perché sono propriamente i migliori.
I primi album hanno più tempo – ovviamente, dirai – di incamerare ricordi, ma su tutto, non hanno dei predecessori, degli altri album dello stesso o della stessa, con cui essere paragonati. La fruizione del primo prodotto di un artista è scevra dal fantasma sclerotizzato del passato, è priva di aspettative, e permette a chi ascolta di accogliere interamente, esatto, non di accettare.
I primi dischi portano con sé la fenomenale spregiudicatezza di chi si lancia verso l’ignoto, di chi ha fame di strappare la carne dei dinosauri precedenti. I primi dischi sono quasi completamente ignari di cosa la major e tutta la squadra chiedono, conservano quasi intatto e tradotto l’incredibile potere illusorio dell’immaginazione che – come sosteneva Napoleone davanti ai sudditi che si strappavano i capelli e piangevano di gioia davanti a lui- governa il mondo. I primi dischi sono ancora quasi immacolati dal compromesso, sono l’espressione di chi crea tirata a lucido, un audace tentativo capace di stare in bilico tra la fortuna e il quasi anonimato.
Anche qui, il tempo, la mancanza di aspettative, le poche pressioni allo spirito creatore e la sua forza immaginifica, diventano delle gocce corrosive che scavano la membrana della superficie musicale, permettendo al “primo disco” di andare più nel profondo, lasciandogli la possibilità di acquisire senso, significato e, su tutti, ricordi condizionati e incondizionati.
Il primo prodotto è il primo confine tremolante, il tratto grezzo che delimita l’idea che hai di un artista, chi è e chi non è, cosa non fa, cosa non fa. La TUA (e solo tua) idea prende forma nel corso dell’ascolto, si costruisce come il Gigante di Ferro si ricostruiva attirando a sé i componenti della sua struttura: dai brani scanzonati cerchi di comprendere il suo umorismo, dai brani love come ama, chi ama, dai brani ragionati il suo modo di pensare e via dicendo. Da un ascolto soddisfacente del primo album crei un personaggio dell’artista, il tuo personale avatar. Da quel preciso momento in poi nasce il rapporto con chi ha creato e con la sua musica. Un rapporto immaginario, immaginifico, ma che è di vitale importanza per mantenere in vita la musica e il nostro sé infantile pronto a meravigliarsi.
Ciò che, infatti, riesce a conferire così tanta forza al primo disco, tanto da diventare il migliore per una buona parte del pubblico, oltre ai ricordi, all’imprevedibile uscita, è l’assistere all’incredibile miracolo della vita artistica che viene al mondo. Come ci si emoziona davanti allo sbocciare di un fiore, o alla nascita di una farfalla da un bozzolo, così ci si può emozionare davanti alla nascita di una nuova vita artistica. Che soddisfazione proviamo nel dire di conoscere un artista da quando ha iniziato a fare musica? E quanto ci piace sottolineare che lo seguivamo “dal giorno zero”.
Tutto questo non è strettamente collegabile al misterioso arcano della vita una persona che si ribattezza con un nome d’arte e si fa conoscere al mondo con un nome diverso da quello di battesimo scelto dai propri genitori?
Quindi, il primo disco di un artista è sempre il migliore? Non per forza. Forse il migliore è il primo disco che si ascolta veramente, non importa se è il primo, il secondo o il decimo, perché quell’esperienza emozionale diventa davvero irripetibile. Per il secondo disco, invece, bisogna fare un altro tipo di discorso.
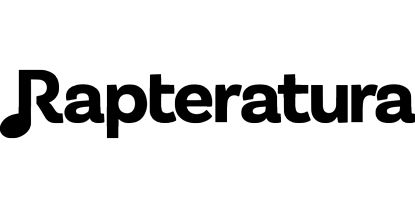
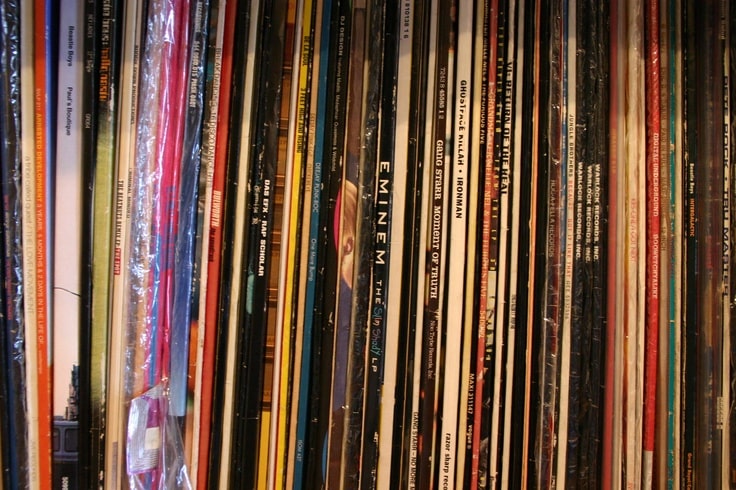






Nessun commento!